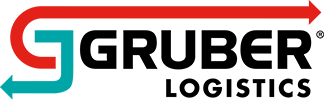Un tempo, i porti venivano concepiti semplicemente come nodi di rottura di carico, cioè luoghi in cui la merce passava da un mezzo di trasporto all’altro, con frequente movimentazione diretta delle merci. Per comprendere l’evoluzione che ha interessato il ruolo dei porti nel sistema logistico, occorre partire da alcune definizioni fondamentali. Secondo una classificazione tradizionale, gli elementi che costituiscono il trasporto sono quattro: la via (cioè il tracciato su cui si muove il veicolo), il veicolo stesso, i punti di fermata (come le stazioni o i porti) e la forza motrice.
La modalità di trasporto si distingue in base alla via utilizzata: terrestre, marittima, aerea, fluviale. Si parla di “rottura di veicolo” quando la merce viene trasferita da un mezzo a un altro, e di “rottura di carico” quando la merce viene rimossa dall’unità che la contiene. Nel passato, nei porti avvenivano entrambe: la merce veniva scaricata dalle navi e poi caricata su altri veicoli, comportando spesso la manipolazione diretta del carico.
I porti marittimi, dunque, si configuravano come punti di fermata obbligati nella modalità marittima, dove si verificava il cambio modale verso il trasporto terrestre, con una rottura di carico praticamente inevitabile. Questo obbligava a sviluppare nei porti competenze sia nella gestione del traffico marittimo sia nell’organizzazione del trasporto terrestre verso l’hinterland. In altre parole, il porto era già, nei fatti, un luogo di pianificazione logistica, ancor prima che la logistica diventasse una disciplina autonoma.
I porti dotati di più modalità di trasporto — marittima, terrestre, fluviale — si sono naturalmente evoluti in centri logistici avanzati. Ne sono esempio i grandi porti olandesi, dove si trovano importanti centri di formazione logistica, o realtà italiane come Venezia. Inoltre, molte delle principali case di spedizione si sono sempre insediate nei porti, proprio per coordinare efficacemente i diversi segmenti del trasporto.
Tuttavia, la rottura di carico, così come era concepita prima della containerizzazione, comportava costi elevati di movimentazione. Le merci venivano caricate direttamente nella stiva delle navi in sacchi, botti, casse di legno o con imbragature, e questo processo richiedeva molta manodopera e tempo. Per ridurre questi costi, era spesso conveniente lavorare le merci direttamente nei pressi del porto: da qui nasce l’associazione storica tra città portuali e centri industriali. Le lavorazioni industriali venivano effettuate immediatamente a ridosso del punto di sbarco. Così, ad esempio, nacquero le torrefazioni di caffè ad Amburgo, Napoli o Trieste, o le imprese molitorie a Venezia. A Londra, l’industria si sviluppò anche grazie a questa logica, e lo stesso vale per settori come la siderurgia o le centrali termiche.
La situazione cambia radicalmente a partire dalla metà del Novecento, con l’introduzione delle unità di carico standardizzate. Inizia così l’era dell’intermodalità moderna. Due date fondamentali
segnano questa svolta: nel 1956 Malcom McLean sviluppa il container ISO, e nel 1957 viene varata la prima nave Ro-Ro per navigazione d’altura, la S/S Comet. Pur considerando che l’intermodalità non si limita solo al container, quest’ultimo è diventato il simbolo della trasformazione logistica globale.
Oggi i carichi alla rinfusa costituiscono ancora la maggioranza del traffico marittimo in termini di volume, ma la crescita del traffico containerizzato, soprattutto dagli anni ’90, è evidente. La containerizzazione ha infatti rivoluzionato le operazioni nei porti. Non si maneggia più la merce direttamente, ma si movimentano i contenitori che la custodiscono. Queste “scatole” possono viaggiare via mare, strada o ferrovia senza che la merce al loro interno venga toccata. Si parla quindi, nel linguaggio comune della logistica, di assenza di rottura di carico durante il cambio modale.
Essendo standardizzati, questi contenitori sono gestiti in modo uniforme ovunque. I porti hanno sviluppato terminal dedicati, le operazioni sono diventate più veloci, sicure ed economiche. È proprio questa semplicità ed efficienza a rendere il container una delle innovazioni più rivoluzionarie nella storia dei trasporti. La possibilità di spostare una stessa unità dalla fabbrica al cliente finale — il cosiddetto door-to-door — senza manipolare direttamente la merce ha dato un’enorme spinta alla globalizzazione dei commerci.
Oggi i porti sono veri e propri centri di gestione integrata dei sistemi logistici. Ciò significa non solo movimentare container, ma anche pianificare il loro inoltro nell’entroterra, spesso tramite ferrovia, verso terminal interni. Le attività economiche coinvolte in questo processo — spedizionieri, operatori logistici, terminalisti — si concentrano nei porti e ne fanno parte della cosiddetta “comunità portuale”.
Tra questi attori troviamo, ad esempio, i Multimodal Transport Operators (MTO), che organizzano e gestiscono il trasporto intermodale delle unità di carico. Molti MTO nascono o hanno sede nei porti stessi, proprio per presidiare questo snodo cruciale. A fianco degli operatori privati, esistono anche soggetti pubblici o misti, come le Autorità di Sistema Portuale in Italia, che coordinano l’attività complessiva dei porti e ne promuovono lo sviluppo.
In conclusione, i porti non sono più soltanto luoghi dove si carica e si scarica la merce: sono diventati sistemi logistici complessi, interconnessi con reti di trasporto e flussi commerciali globali. Da semplici nodi, si sono evoluti in veri e propri cervelli operativi della logistica moderna.